III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) – Lectio divina
Es 3,1-8.13-15 Sal 102 1Cor 10,1-6.10-12

O Dio dei nostri padri,
che ascolti il grido degli oppressi,
concedi ai tuoi fedeli
di riconoscere nelle vicende della storia
il tuo invito alla conversione,
per aderire sempre più saldamente a Cristo,
roccia della nostra salvezza.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro dell’Èsodo Es 3,1-8.13-15
Io-Sono mi ha mandato a voi.
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb.
L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava.
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele».
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?».
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione».
Vocazione e missione di Mosè
Mosè, costretto a fuggire, da una parte perde la sua libertà e l’appartenenza alla famiglia del faraone, ma dall’altra, partecipa più direttamente al dramma che stava colpendo il suo popolo. Nel suo vagare trova casa presso la famiglia di Ietro di cui sposa la figlia, entrando al suo servizio. Ietro era anche sacerdote di Madian; Mosè non solo si integra nella sua famiglia ma assimila anche la cultura e il culto di quel popolo straniero che lo ha accolto e fatto vivere. Tuttavia, mentre la sua vita sembrava ormai destinata ad essere condotta in un paese lontano in mezzo ad un popolo straniero, Dio si manifesta a lui affidandogli la missione di salvare il suo popolo. Non è più Mosè che va di sua spontanea volontà a trovare i fratelli ma è Dio che lo invia. Egli davanti al roveto ardente, che non si consuma, si avvicina per comprenderne il motivo, ma Dio lo rimprovera perché non può avvicinarsi al “fuoco” come vuole. Davanti al mistero, sia esso dell’iniquità o della salvezza, bisogna sempre avere un atteggiamento di prudenza e rispetto limitando la istintiva tendenza dominante e controllante. La manifestazione di Dio rivela che non solo quella terra, ma ogni “terrestre” appartiene a Dio e non può essere calpestata. È un messaggio rivolto a Mosè e, attraverso di lui, al faraone che umilia e terrorizza gli Israeliti. Mosè si copre il volto perché riconosce che è alla presenza di Dio e che la sua povertà renderebbe insostenibile la visione. È un gesto di umiltà e di timore reverenziale che comunque non gli impediscono di entrare in dialogo con Dio e di chiedere spiegazioni circa la missione affidatagli. Egli, che si era rivestito di autorità e aveva preteso di fare giustizia a modo suo, ora riceve autorevolezza dalla parola di Dio. Mosè non ottiene strumenti bellici o ricchezze per convincere il faraone a lasciar andare Israele ma andrà solamente forte del comando di Dio. Quanto più Mosè custodirà la Parola tanto più Dio sarà con lui manifestandone la potente efficacia. Il soggetto principale della liberazione è Dio e il suo fine è l’incontro del Popolo con Lui. Si delinea l’itinerario spirituale dell’esodo e la vocazione dell’intero popolo d’Israele: passare dalla schiavitù al servizio.
Mosè si prepara alla missione presso i suoi fratelli anticipando quelle che potrebbero essere le loro domande. Egli, infatti, si sarebbe presentato come profeta, ma di quale Dio? Il nome che Dio gli comunica è misterioso e alla lettera può essere tradotto in diversi modi. Una delle traduzioni più interessanti è: «Io sono colui che voglio essere». L’identità di Dio è definita dalla sua volontà. Negli eventi essa si manifesta come volontà amorevole, sicché il nome di Dio è Amore. La intraducibilità in parole del nome di Dio significa che egli non tollera nessuna forma di riduzione o definizione, peggio ancora, di “confinamento”. Sulla bocca di Mosè basterà la forma più breve e incisiva di «Io sono», quasi a dire che è un Dio di poche parole. Nell’«Io-sono» c’è l’essenziale. Rivelando il suo nome, Dio si fa piccolo come quella piccola parola che l’uomo può porre sulle sue labbra per invocarLo perché Egli gli è vicino, sulla bocca e sul cuore.
Il tratto caratteristico di Dio è la prossimità che non annulla la diversità ma la lontananza. Mosè è inviato come profeta per annunciare la visita di Dio. Egli viene per liberare il suo popolo e guidarlo verso la terra promessa. Essa non è disabitata ma lì incontrerà altri popoli con i quali entrare in dialogo, ma soprattutto verso i quali portare la luce della Parola che fa di popoli diversi un’unica famiglia.
Mosè non è un eroe solitario ma deve coinvolgere e responsabilizzare i suoi fratelli. Dio annuncia che presso di loro troverà credito e, con coloro che accoglieranno la sua parola, dovrà lottare con il faraone. Dio assicura la sua presenza e la sua assistenza. I prodigi saranno segni rivelatori nel nome di Dio. Persino le “piaghe d’Egitto” saranno uno strumento per piegare l’orgoglio del faraone ma anche un’occasione per Israele di purificare la sua fede in Dio credendo nella sua parola e al suo profeta, anche davanti ad evidenze che potrebbero indurre allo scoraggiamento e alla resa.
Salmo responsoriale Sal 102
Il Signore ha pietà del suo popolo.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1Cor 10,1-6.10-12
La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata scritta per nostro ammonimento.
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto.
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono.
Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere.
La storia insegna e ammonisce
Affrontando la questione degli «idolotiti», San Paolo tratta anche il tema della libertà del cristiano che si esercita insieme con la carità fraterna per non essere «squalificato» (9,27). Gli idolotiti sono le carni degli animali sacrificati agli idoli, non utilizzati nei banchetti sacri, ma vendute al mercato o consumate nei pressi del tempio. I cristiani di Corinto erano divisi a tal riguardo. Qualcuno temeva di venire a patti con l’idolatria. I «forti», consapevoli della inconsistenza degli idoli, erano favorevoli alla consumazione di quelle carni, mentre i «deboli» erano più scrupolosi e si scandalizzavano. I «forti» si dichiaravano liberi di mangiare quel tipo di carne, ma l’apostolo corregge le loro affermazioni ricordando che per il cristiano la libertà si coniuga sempre con la carità, la quale si declina nel rispettare le opinioni dei «deboli» verso cui bisogna avere attenzione e pazienza. Infatti, la carità deve superare la libertà del proprio giudizio. Paolo offre sé stesso come esempio di credente che certamente si rende libero rispetto ai condizionamenti della Legge, ma nel contempo esercita la libertà rinuncia a certi diritti che la sua condizione di apostolo gli venivano riconosciuti per mostrare la carità verso tutti. La tesi dei «forti» presa in sé è legittima, ma calata nella realtà diventa fonte di divisione nella comunità. Il rimanere fissi su questioni di principio può generare contrapposizioni nella comunità e passare dalla parte della ragione a quella del torto perché si è causata una frattura nella Chiesa. Il vero pericolo è dunque quello di essere «squalificato» cioè di uscire dalla comunione che è il vero senso della fede. Paolo esorta a fare tesoro della storia dell’esodo e a non perpetuare il peccato d’Israele che, nonostante le molteplici prove della fedeltà di Dio, continuamente lo provocava mettendo in dubbio il suo amore. La mormorazione è la lamentela che ha origine da un cuore irriconoscente e, perciò stesso, infedele. La libertà è un’occasione che è data a tutti da Cristo, roccia dalla quale è scaturita l’acqua dello Spirito Santo. Questa occasione può andar perduta se si oppone resistenza alla grazia di Dio.
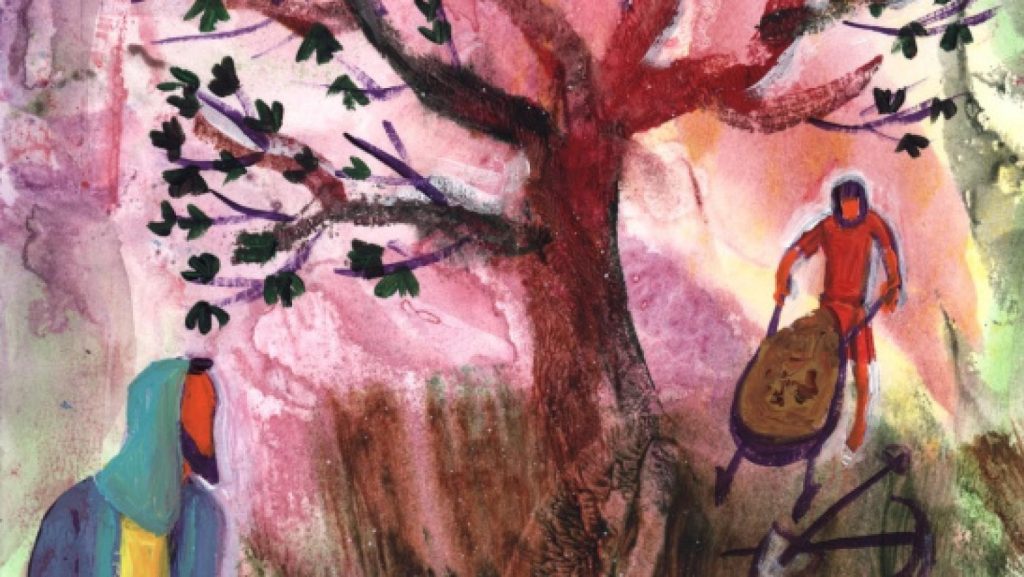
Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,1-9
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo.
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
Lectio
Contesto
Con 9,51 inizia il cosiddetto «grande viaggio» verso Gerusalemme (9,51-19,44), cioè cammino verso la morte e ascesa al Padre. Questa sezione, che rappresenta quasi un terzo di tutto il vangelo, può essere indicativamente suddivisa in quattro parti, di cui le prime tre riguardano il viaggio verso la Città santa dove si compie la Pasqua (9,51-13,21; 13,22-17,10; 17,11-19,27; 19,28-44). Le sezioni individuate sono caratterizzate da brevi sommari che possono essere letti come elementi strutturali e di transizione. L’evangelista procede per ondate successive presentando Gesù in dialogo con i discepoli, le folle e gli avversari. Il Maestro continua a svolgere la medesima missione già narrata nella precedente sezione (4,14-9,50), cioè annunciare il regno di Dio: alle folle ne parla in parabole, con i discepoli il discorso è più diretto. Anche i «settantadue» missionari sono inviati a portare il medesimo annuncio. L’annuncio della vicinanza del regno di Dio è l’elemento caratterizzante di tutto il viaggio.
La prima delle tre sezioni del «grande viaggio» (9,51-13,21) mette a tema l’esistenza credente: Cosa significa diventare discepoli? Come vivere la sequela? Quattro temi strutturano questo arco narrativo: la missione dei discepoli, che come Gesù sono rifiutati ma anche accolti (9,51-10,42); la preghiera (11,1-13); il discernimento dei segni dei tempi (11,14-12,59); la crescita del Regno (13, 1-21).
Il contesto immediato della pericope liturgica è l’appello molto deciso alle folle (vv.54-59) perché prendano una decisione: il tono è urgente e severo, quasi per evitare il peggio. Il linguaggio risente di un certo influsso apocalittico ed escatologico: il tempo si è fatto breve, è necessario fare una scelta di conversione per portare frutto.
Testo
Al centro della pagina evangelica c’è un appello accorato alla conversione verso Dio paziente e misericordioso. La pericope liturgica mette a confronto due visioni teologiche riguardanti i drammi della storia e le sue implicanze con la fede. L’occasione è offerta da un episodio drammatico che viene riferito a Gesù. Pilato ha dato ancora una volta prova della sua ferocia sopprimendo nel sangue un primo accenno di rivolta. Quel che è peggio, è che ha ucciso anche coloro che si erano rifugiati nel tempio dimostrando anche il disprezzo verso il luogo sacro. La risposta di Gesù stigmatizza l’interpretazione soggiacente alla narrazione del fatto accaduto. Il punto di vista dei suoi interlocutori si concentra sull’ingiustizia perpetrata a danno dei Galilei di cui si ricerca la causa e il colpevole. L’indignazione si trasforma in atto di accusa verso Pilato ma serpeggia la mormorazione anche contro Dio che, non intervenendo a salvare la vita di coloro che erano nel tempio, ha permesso che si consumasse quella carneficina. L’unico motivo che avrebbe potuto giustificare l’omissione di soccorso era la colpevolezza degli assassinati. La posizione di Gesù è netta. Rigetta con forza un tale modo di ragionare e invita una prima volta a non fermarsi alle analisi fuori di sé stessi incolpando gli altri ma di cogliere nel dramma un’occasione per verificare sé stessi, riconoscere la propria colpa e chiedere perdono a Dio.
Gesù rincara la dose ricordando un altro evento luttuoso. Qualche tempo prima una torre era crollata su diciotto persone che erano rimaste uccise sotto le macerie. In questo caso non c’è una mano armata contro cui puntare il dito, ma anche quello che sembra essere una fatalità, è letta secondo il criterio della giustizia retributiva per la quale le vittime passano per colpevoli. La ripetizione dell’insegnamento di Gesù sottolinea con forza l’urgenza di convertirsi, ovvero di cambiare modo di pensare. Il verbo convertire non allude al cambiamento di religione ma al radicale mutamento di vivere la fede perché essa non è un dettaglio trascurabile della vita ma ciò da cui dipende il suo successo o il suo fallimento, la sua fecondità o la sua sterilità. La conversione implica un nuovo orientamento con un cambiamento di mentalità a proposito di Dio e della vita dell’uomo. La conversione così intesa permette di passare dal credere in un Dio giustiziere e castigatore a sperare nella sua giustizia misericordiosa.
La piccola parabola del fico richiama la tradizione profetica, voce della lamentazione di Dio verso il suo popolo. La lamentazione è una preghiera con la quale si offre all’altro l’amarezza del proprio dolore spinti dall’unico desiderio di ristabilire la giustizia con la riconciliazione. La cura con la quale Dio si fa carico del dolore e delle speranze d’Israele, privo di qualsiasi merito nei suoi confronti, è ben espressa nelle parole con le quali si presenta a Mosè dal roveto ardente. Nella parabola un uomo va verso il fico piantato nella sua terra per cercare i frutti. In questa immagine si riflette la scelta di Dio di andare verso il suo popolo e di cercarlo per offrirsi come liberatore e guida. È il modo con cui risponde al grido di aiuto che si innalza dal popolo che soffre il dramma della schiavitù. I frutti attesi dal popolo sono le sue opere di giustizia e di misericordia che danno senso alla sua esistenza. Come un albero è piantato perché porti frutto, così Israele è scelto da Dio, e posto nella terra promessa, perché manifesti mediante la giustizia la sua misericordia. La sterilità del fico è il risultato della chiusura mentale e della durezza di cuore dell’uomo che invece di obbedire a Dio gli oppone resistenza. L’infruttuosità è la morte, come la incredulità è ciò che la causa. Il proprietario del fico sterile non giudica condannando ma semplicemente denuncia quale sia l’epilogo di una vita vissuta all’insegna dell’opportunismo e dello sfruttamento senza tradurre la cura ricevuta in frutto. D’altra parte, l’intervento del vignaiolo mette in luce la pazienza con la quale Dio si prende cura di noi. Gesù, nella sinagoga di Nazareth, ha predicato un anno di grazia per il Signore. Il tempo della nostra vita, seppure attraversata da prove e sofferenze varie, è tempo di grazia, ovvero il tempo opportuno affinché s’impari l’arte dell’obbedienza e della pazienza per lavorare su sé stessi invece di perdere tempo a lamentarci degli altri e a colpevolizzarli. Il vignaiolo e il padrone concordano sul concedere ancora tempo che non è semplicemente di attesa passiva ma attiva da parte del vignaiolo. Egli non solo propone al padrone una dilazione al giudizio finale ma si impegna ad intensificare la sua opera di cura. La parabola ha una finale aperta che interpella l’uditorio il quale, avverte la responsabilità di prendere una decisione chiara e accoglie il senso positivo dell’appello. La vera notizia è quella che dà Gesù nel momento in cui annuncia il vangelo della misericordia che alimenta e orienta la speranza verso la salvezza che Dio offre ad ogni uomo.
Meditatio
La pazienza, la grazia nella disgrazia
Parlando ai Filippesi s. Paolo esorta ad attendere Gesù Cristo che viene a trasfigurare il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. La conversione, oggetto dell’appello urgente lanciato da Gesù nel vangelo, consiste esattamente in questa trasformazione che è un’operazione condotta a quattro mani, per così dire. Infatti, la conversione avviene quando l’uomo e Dio dialogano tra loro, come la trasfigurazione di Gesù avvenne mentre era in preghiera. Non si tratta di un cambiamento solamente estetico o formale, ma della mente, ovvero del proprio modo di pensare e, dunque, di relazionarsi con Dio e con i fratelli. La preghiera è l’incontro tra l’uomo misero e Dio misericordioso. Nella pagina evangelica due fatti di cronaca nera fanno da sfondo all’insegnamento di Gesù. Il vangelo non prescinde dalle esperienze tragiche della vita nelle quali l’uomo sperimenta drammaticamente la sua strutturale povertà, precarietà e insufficienza. Anche nel deserto, durante il tempo dell’esodo, Israele ha vissuto il dramma della fame e della sete che ha fatto loro dimenticare le grandi opere compiute da Dio per liberarli dall’Egitto. Anzi, nella prova gli Israeliti, si sono ribellati a Lui coltivando la nostalgia della schiavitù quando, per lo meno, avevano le cipolle con cui sfamarsi. Quando la nostalgia prende il posto della speranza la fiducia si spegne ma si accende lo sdegno e la mormorazione. Il messaggio centrale risiede nell’esortazione a non abbandonare la preghiera nel momento della sofferenza perché l’ascolto della Parola di Dio rianima il ricordo dell’amore di Dio, rasserena il cuore e rende gli occhi della mente più lucidi per fissare lo sguardo sulla meta del nostro esodo esistenziale stabilita nel Cielo. Nel dialogo con Mosè Dio rivela la sua identità di Signore della storia. Il nome «Io Sono» è il nome di Dio che si fa compagno di strada dell’uomo soprattutto nella fatica e nel dolore. L’amore di Dio è misericordioso e paziente perché ha sempre fiducia nelle nostre capacità, come il vignaiolo della parabola raccontata da Gesù. Infatti, nonostante la nostra durezza di cuore e la sterilità spirituale, non si stanca di amarci con tenerezza e tenacia. Ribellarsi a Dio rende infruttuosa la nostra condizione umana, povera ma potenzialmente feconda. Al contrario, la fede, vissuta in dialogo con la Parola di Dio, si traduce in opere di giustizia e di misericordia in favore dei fratelli anche in un contesto sfavorevole come può essere quello del deserto, simbolo della solitudine e di ogni tipo di prova. Il vignaiolo parla di un anno nel quale intensificare il lavoro per rendere produttivo l’albero. Il tempo della quaresima ci ricorda che la nostra vita terrena è il tempo che viene offerto per lasciarci convertire e per trasformare la provvidenza divina in dono d’amore agli altri. Da qui l’invito di Gesù a vivere il tempo della vita come esercizio di una continua conversione aprendo il cuore all’azione di Dio con la preghiera soprattutto nel momento delle prove dolorose. Il dono della pazienza, grazia nella disgrazia, ci insegna a saper rimanere saldi nella fede quando siamo nel turbinio del dolore, in modo da non scadere nella mormorazione e nella colpevolizzazione ma di perseverare nel bene per produrre frutti di giustizia e di misericordia in ogni tempo.
Oratio
Signore Gesù,
Tu che nella prova sei stato istigato dal diavolo
a tentare Dio e a sfidarlo per dimostrare
che veramente ti era Padre,
aiutaci a non perdere la fiducia in Lui
quando il dramma della malattia ci umilia
e la spada della morte ci ferisce.
Insegnaci a pregare
offrendo a Dio il nostro dolore
affinché i traumi non si mutino
in rabbia aggressiva e colpevolizzante.
Donaci la pazienza
di saper stare con Te
nella sofferenza per perseverare
nel bene e nella comunione fraterna.
Tra le tenebre dello sconforto illumina la mente
per intravedere la luce della tua consolazione
che ci guida e per sentire nella nostra solitudine
il sostegno della tua mano forte e tenera. Amen.

Commenti recenti